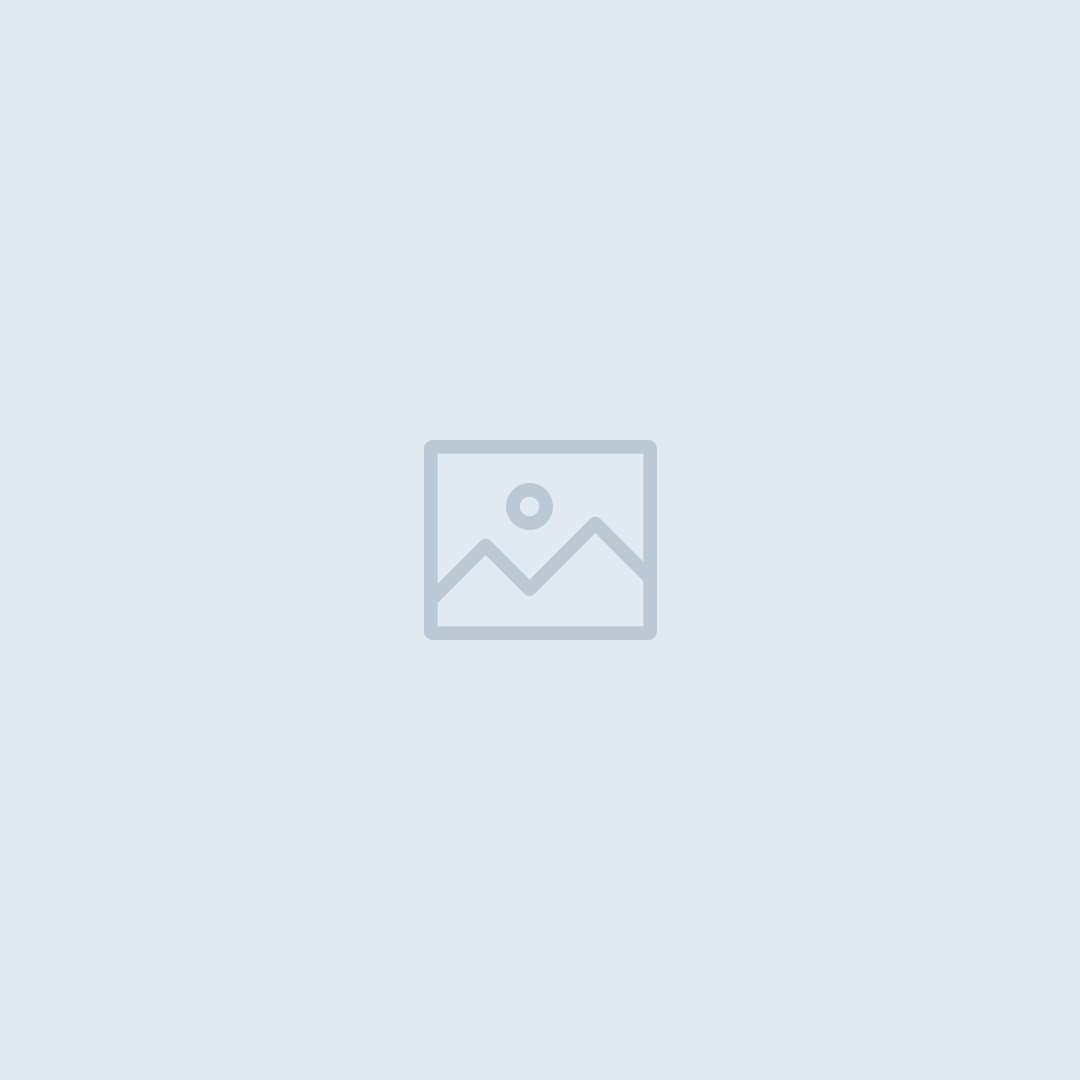La città di Giulietta e Romeo e dei grandi spettacoli lirici nell’Arena romana, degli aperitivi in piazza delle Erbe e delle passeggiate lungo l’Adige con lo sguardo che indugia sui campanili delle tante chiese e spicca il volo verso le colline. Adagiata tra due anse del fiume e circondata a nord-est dagli ultimi rilievi prealpini digradanti verso la pianura, Verona (m 59, ab. 250.000 ca.) è il secondo capoluogo di provincia della regione per importanza economica, grazie anche alla posizione allo sbocco della via del Brennero che ne ha fatto da sempre uno dei principali nodi d’interscambio con i paesi d’oltralpe, oltre che la mediatrice storica tra Veneto e Lombardia
L’abitato romano, cinto da mura, si estendeva nell’ansa dell’Adige dove decumano (gli attuali corsi Porta Bórsari e S. Anastasia) e cardo (vie S. Egidio, Cappello e Leoni) si incontravano nell’area dell’attuale [B]piazza delle Erbe[/B], corrispondente al foro. Questo è il cuore antico di Verona, su cui si sono sovrapposti gli interventi urbanistici di epoca scaligera, conferendo alla zona una spiccata atmosfera medievale. Piazza delle Erbe, affollata dal caratteristico mercato e dai tavolini all’aperto dei numerosi bar, alla sera, quando si smontano le bancarelle, recupera tutto il suo impatto scenografico. Al centro, la colonna del Mercato (1401), edicola gotica con le insegne viscontee; la cinquecentesca berlina, un baldacchino per le investiture pubbliche; la fontana di Madonna Verona sistemata intorno al 1368 recuperando una statua romana; la colonna di S. Marco (1523). Da qui, ogni scorcio della piazza ha i suoi motivi di suggestione: sul lato sinistro (sud-ovest) spicca la trecentesca casa dei Mercanti, a bifore e merli; in quello di fondo, la torre del Gardello o delle Ore (1370) e il tardobarocco palazzo Maffei; sul lato destro (nord-est), ai nn. 24-36 le case Mazzanti (secoli XIV-XVI), decorate da affreschi cinquecenteschi, la Domus Nova, il palazzo del Comune e l’arco della Costa (1470), cosiddetto per la costa di balena sospesa sotto la sua volta, che introduce in [B]piazza dei Signori[/B].
Quest’ultima, un tempo sede delle pubbliche istituzioni cittadine, è chiusa come un cortile da edifici monumentali collegati da arcate; al centro campeggia il monumento a Dante (1865). A partire da destra, [B]palazzo del Comune[/B] o della Ragione, il cui impianto risale alla fine del XII secolo, si distingue per il cortile romanico porticato, detto Mercato Vecchio, dominato dalla scala esterna del XV secolo in marmo rosso veronese. Nel palazzo è inglobata la torre dei Lamberti (84 m), innalzata a partire dal 1172 e completata a metà del ’400, dalla cui cima si gode un’ampia veduta sul centro storico. Il complesso è stato scelto come sede di un moderno centro espositivo polivalente. Il [B]palazzo del Capitanio[/B], già Tribunale, è edificio trecentesco sistemato nell’800 con un torrione scaligero e un portale di Michele Sanmicheli. Chiude in fondo la piazza il [B]palazzo della Prefettura[/B], l’antica residenza degli Scaligeri che ospitò Dante e Giotto. Costruito nel ’300, il palazzo fu ripristinato dai restauri del 1929-30 nell’aspetto originario; il portale è di Sanmicheli (1533). La loggia del Consiglio, costruita verso la fine del XV secolo come sede del Consiglio cittadino, per la purezza delle linee e l’armonia della decorazione è considerata una delle espressioni più alte del rinascimento veronese; il rivestimento policromo e la decorazione scultorea (le statue rappresentano i veronesi illustri di età romana:
Catullo, Plinio, Emilio Macro, Vitruvio e Cornelio Nepote) movimentano il prospetto dell’edificio. Un arco sormontato da una statua cinquecentesca unisce la loggia alla casa della Pietà, ricostruita nel 1490. Più a sinistra, la piazza è chiusa dalla [B]Domus Nova[/B], già palazzo dei Giudici, ricostruzione secentesca dell’edificio scaligero destinato a residenza del podestà.
Nel [B]piazzaletto delle Arche scaligere[/B], uno degli angoli più suggestivi della città, sorgono la chiesetta
romanica di S. Maria Antica (XII secolo), dal grazioso interno, e le “arche”, monumentali tombe dei Della Scala, signori di Verona. Sopra il portale della chiesa, l’arca di Cangrande I, morto nel 1329, con la copia della statua equestre del condottiero (l’originale è a Castelvecchio). A due passi, via Sottoriva, una delle poche ancora fiancheggiate da portici, corre a un livello inferiore rispetto al lungofiume, sul probabile sito del porto romano; le rustiche osterie di un tempo hanno oggi lasciato il posto a numerosi localini alla moda, frequentati soprattutto da giovani. In fondo alla via campeggia S. Anastasia, chiesa gotica interamente in cotto
eretta dai domenicani tra il 1290 e il 1481 e restaurata a fine ’800. La facciata, con superbo portale gemino trecentesco, è incompiuta; le belle absidi poligonali sono sovrastate dal campanile tardoquattrocentesco.
All’interno, il primo altare a destra è di Sanmicheli (1565); nel presbiterio, grande affresco (Giudizio universale) del cosiddetto Maestro del Giudizio universale (XIV secolo). Dal transetto sinistro, per una porta ogivale si accede alla cappella Giusti, nella quale è custodito il prezioso affresco staccato di Pisanello, San Giorgio che parte per liberare la donzella dal drago.
Imboccata via Duomo, subito a sinistra, al n. 1 di via Forti sorge il settecentesco [B]palazzo Forti-Emilei[/B] (nel cortile, un’ala romanica), che ospita prestigiose mostre temporanee e, con ingresso dal vicolo Volto Due Mori, la Galleria comunale d’Arte moderna e contemporanea Achille Forti, con opere di artisti dell’800 e del ’900, tra cui Francesco Hayez, Giovanni Fattori, Mosè Bianchi, Filippo De Pisis, Umberto Boccioni e sculture di Medardo Rosso, Giacomo Manzù e Giovanni Dupré. Percorrendo la via fino in fondo, si giunge al Duomo, che domina l’appartata piazza omonima. Edificio romanico (XII secolo) con interventi gotici e aggiunte rinascimentali, vanta un monumentale protiro a due ordini ornato di rilievi di Maestro Nicolò (1139); il campanile cinquecentesco (romanico alla base), disegnato da Sanmicheli, è rimasto incompiuto. L’abside in tufo del XII secolo, una delle più pure espressioni dell’arte romanica veronese, è fasciata da lesene e da un bel fregio nella cornice. L’interno gotico presenta ampie arcate su alti pilastri; nelle cappelle e nel presbiterio, chiuso da un notevole deambulatorio absidale semicircolare a colonne di Sanmicheli (1534), sono vari dipinti e sculture dei secoli XIV-XVI.
Sulla sinistra del Duomo si apre il [B]chiostro romanico[/B] su colonnine binate (1140 ca.), con resti di mosaici pavimentali della basilica paleocristiana; da qui si può accedere alla chiesetta di S. Elena, romanica su strutture paleocristiane, e all’antico battistero di S. Giovanni in Fonte, con vasca battesimale ottagona duecentesca. A sinistra del Duomo, la [B]Biblioteca capitolare[/B] è una delle più antiche (risale al V secolo) e importanti biblioteche ecclesiastiche d’Europa. Custodisce, fra i manoscritti più preziosi, il Virgilio del IV secolo, il codice di Giustiniano del VI secolo, vari libri miniati e l’archivio dei Canonici, con 11.000 pergamene.
Al pianterreno dello stesso edificio ha sede il [B]Museo Pinacoteca canonicale [/B]con pitture e sculture che vanno dal ’300 all’800.
Al n. 2A di via S. Mamaso, nell’omonimo palazzo quattrocentesco, il [B]Museo Miniscalchi-Erizzo[/B] espone in sedici sale raccolte archeologiche, bronzi, sculture, maioliche, armi, armature, disegni e dipinti di maestri veneti dei secoli XVI-XVII. Poco distante, in una via costeggiata da numerose residenze nobiliari, si staglia S. Eufemia, lunga e stretta costruzione gotica ultimata nel
XIV secolo, con un bel portale del 1476; svuotata e trasformata nel 1739, conserva affreschi del XIV secolo e dipinti di scuola veneta dal ’300 al ’500.
Parallelo a via Emilei, corso di [B]Porta Bórsari [/B]è una tipica via della vecchia Verona che segue il tracciato del decumano massimo romano, costeggiando la chiesetta romanica di S. Giovanni in Foro, fino alla porta dei Bórsari, il principale ingresso alla città romana; il nome, medievale, deriva dai bursarii, gli addetti alla riscossione delle gabelle vescovili.